Gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario aspettando la pronuncia delle Sezioni Unite.
Il rapporto tra processo penale e processo tributario è da sempre governato nel nostro Ordinamento dal principio del “doppio binario”. Tale principio, sancito storicamente dell’articolo 20 del D. Lgs n. 74/2000, stabiliva una netta autonomia tra i due procedimenti anche quando vertono sui medesimi fatti. Di conseguenza, non sussisteva alcun rapporto di pregiudizialità e il processo tributario non veniva dunque sospeso in pendenza di quello penale.
La logica alla base di questa separazione risiedeva nella profonda differenza degli strumenti probatori a disposizione nei due giudizi. Difatti, mentre nel processo penale vige la presunzione di innocenza sino a prova contraria “oltre ogni ragionevole dubbio”, nel processo tributario il contribuente è di fatto soggetto a una presunzione di colpevolezza. Questa dicotomia portava (e porta ancora oggi per come si dirà infra) a conseguenze talvolta “kafkiane” come la possibilità per un medesimo soggetto di essere assolto in sede penale per un reato come la falsa fatturazione e, al contempo, essere condannato in sede tributaria per la medesima condotta.
Sebbene l’articolo 654 del codice di procedura penale prevedesse una certa efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, questa era subordinata a due condizioni stringenti: i) che i fatti accertati fossero stati rilevanti per la decisione penale; ii) che la legge civile non ponesse limiti alla prova della posizione soggettiva controversa.
Nella prassi, tuttavia, pur non potendo ignorare completamente la sentenza penale, il giudice tributario la considerava, al più, quale possibile fonte di prova, finendo sistematicamente per disattenderla.
In questo contesto si è inserita la riforma del D.L. 29 giugno 2024, n. 87, che ha introdotto l’articolo 21 bis del D.L. n. 74/2000. Tale norma, successivamente recepita nell’articolo 119 del Testo Unico della Giustizia Tributaria (T.U. 14 novembre 2024, n. 175), stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario relativo agli stessi fatti materiali. L’efficacia si estende anche a persone fisiche e enti nell’interesse dei quali un soggetto ha agito e ciò al fine di armonizzare il meccanismo del doppio binario con i principi generali dell’Ordinamento e, in particolare, con l’art. 53, comma 1, della Costituzione, che impone – quale requisito strutturale dell’obbligazione tributaria – la sussistenza fattuale del presupposto impositivo.
Tuttavia, con la sentenza delle Sezione V, n. 3800 del 14 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione che, secondo molti autori, si pone in contrasto con la volontà del Legislatore. La Suprema Corte ha statuito, infatti, che l’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario riguarderebbe esclusivamente la sanzione e non l’accertamento dell’imposta.
Secondo questa lettura – motivata, evidentemente, da “necessità di cassa” – il soggetto assolto in sede penale non sarebbe automaticamente “assolto” in sede tributaria per quanto riguarda la pretesa impositiva. L’interpretazione offerta dalla Corte porta ad affermare che l’applicazione estensiva del giudicato penale renderebbe meno efficiente l’accertamento dei tributi, facendo emergere un principio secondo cui l’interesse primario dello Stato è recuperare risorse finanziarie ad ogni costo. Di fatto, chi subisce un accertamento fiscale viene considerato un evasore anche a fronte di una sentenza penale di assoluzione.
L’interpretazione della Cassazione solleva dubbi di compatibilità con il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 3, par. 1, del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Tali norme, come è noto, vietano non solo di punire due volte un soggetto per lo stesso fatto, ma anche di sottoporlo a plurimi procedimenti sanzionatori.
Del resto, avallando la tesi di cui alla Sentenza n. 3800/2024, si esporrebbe il contribuente ad un triplice accertamento (con buona pace dei principi di tutela tanto nazionali, che sovranazionali), ossia: i) un giudizio penale sulla condotta; ii) un primo giudizio tributario sulla fondatezza della pretesa impositiva; iii) un secondo giudizio tributario sull’applicazione delle sanzioni.
Data la delicatezza e della problematicità della questione in esame, la stessa sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 4 marzo 2025 n. 2714 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della mancata estensione al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile sul reato tributario.
Sarà, quindi, il massimo organo della giurisdizione di legittimità a doversi pronunciare sulla corretta interpretazione dell’articolo 21 bis del D.L. n. 74/2000 e sulla legittimità della mancata estensione degli effetti della sentenza penale di assoluzione al rapporto impositivo.
In attesa di tale fondamentale decisione, la questione rimane aperta e conferma la sua cruciale attualità per tutti gli operatori del diritto oltre che, ovviamente, per i contribuenti.
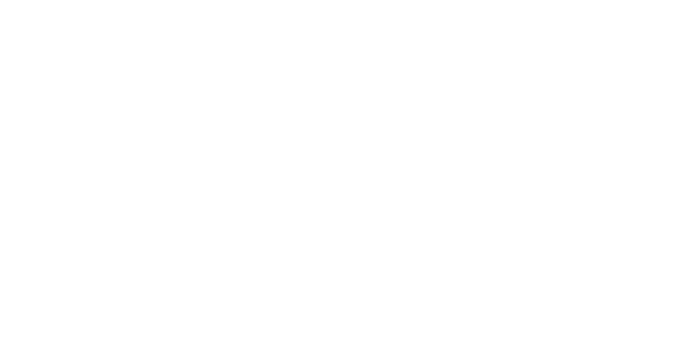
Il doppio binario tra processo penale e processo tributario.
A cura di Giuseppe De Gregorio, Associate
Gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario aspettando la pronuncia delle Sezioni Unite.
Il rapporto tra processo penale e processo tributario è da sempre governato nel nostro Ordinamento dal principio del “doppio binario”. Tale principio, sancito storicamente dell’articolo 20 del D. Lgs n. 74/2000, stabiliva una netta autonomia tra i due procedimenti anche quando vertono sui medesimi fatti. Di conseguenza, non sussisteva alcun rapporto di pregiudizialità e il processo tributario non veniva dunque sospeso in pendenza di quello penale.
La logica alla base di questa separazione risiedeva nella profonda differenza degli strumenti probatori a disposizione nei due giudizi. Difatti, mentre nel processo penale vige la presunzione di innocenza sino a prova contraria “oltre ogni ragionevole dubbio”, nel processo tributario il contribuente è di fatto soggetto a una presunzione di colpevolezza. Questa dicotomia portava (e porta ancora oggi per come si dirà infra) a conseguenze talvolta “kafkiane” come la possibilità per un medesimo soggetto di essere assolto in sede penale per un reato come la falsa fatturazione e, al contempo, essere condannato in sede tributaria per la medesima condotta.
Sebbene l’articolo 654 del codice di procedura penale prevedesse una certa efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, questa era subordinata a due condizioni stringenti: i) che i fatti accertati fossero stati rilevanti per la decisione penale; ii) che la legge civile non ponesse limiti alla prova della posizione soggettiva controversa.
Nella prassi, tuttavia, pur non potendo ignorare completamente la sentenza penale, il giudice tributario la considerava, al più, quale possibile fonte di prova, finendo sistematicamente per disattenderla.
In questo contesto si è inserita la riforma del D.L. 29 giugno 2024, n. 87, che ha introdotto l’articolo 21 bis del D.L. n. 74/2000. Tale norma, successivamente recepita nell’articolo 119 del Testo Unico della Giustizia Tributaria (T.U. 14 novembre 2024, n. 175), stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario relativo agli stessi fatti materiali. L’efficacia si estende anche a persone fisiche e enti nell’interesse dei quali un soggetto ha agito e ciò al fine di armonizzare il meccanismo del doppio binario con i principi generali dell’Ordinamento e, in particolare, con l’art. 53, comma 1, della Costituzione, che impone – quale requisito strutturale dell’obbligazione tributaria – la sussistenza fattuale del presupposto impositivo.
Tuttavia, con la sentenza delle Sezione V, n. 3800 del 14 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione che, secondo molti autori, si pone in contrasto con la volontà del Legislatore. La Suprema Corte ha statuito, infatti, che l’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario riguarderebbe esclusivamente la sanzione e non l’accertamento dell’imposta.
Secondo questa lettura – motivata, evidentemente, da “necessità di cassa” – il soggetto assolto in sede penale non sarebbe automaticamente “assolto” in sede tributaria per quanto riguarda la pretesa impositiva. L’interpretazione offerta dalla Corte porta ad affermare che l’applicazione estensiva del giudicato penale renderebbe meno efficiente l’accertamento dei tributi, facendo emergere un principio secondo cui l’interesse primario dello Stato è recuperare risorse finanziarie ad ogni costo. Di fatto, chi subisce un accertamento fiscale viene considerato un evasore anche a fronte di una sentenza penale di assoluzione.
L’interpretazione della Cassazione solleva dubbi di compatibilità con il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 3, par. 1, del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Tali norme, come è noto, vietano non solo di punire due volte un soggetto per lo stesso fatto, ma anche di sottoporlo a plurimi procedimenti sanzionatori.
Del resto, avallando la tesi di cui alla Sentenza n. 3800/2024, si esporrebbe il contribuente ad un triplice accertamento (con buona pace dei principi di tutela tanto nazionali, che sovranazionali), ossia: i) un giudizio penale sulla condotta; ii) un primo giudizio tributario sulla fondatezza della pretesa impositiva; iii) un secondo giudizio tributario sull’applicazione delle sanzioni.
Data la delicatezza e della problematicità della questione in esame, la stessa sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 4 marzo 2025 n. 2714 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della mancata estensione al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile sul reato tributario.
Sarà, quindi, il massimo organo della giurisdizione di legittimità a doversi pronunciare sulla corretta interpretazione dell’articolo 21 bis del D.L. n. 74/2000 e sulla legittimità della mancata estensione degli effetti della sentenza penale di assoluzione al rapporto impositivo.
In attesa di tale fondamentale decisione, la questione rimane aperta e conferma la sua cruciale attualità per tutti gli operatori del diritto oltre che, ovviamente, per i contribuenti.