Il principio di retroattività delle sanzioni più favorevoli, noto anche come favor rei o principio della lex mitior, può essere derogato?
Verrebbe da dire assolutamente no, considerando che l’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 afferma: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”, e che l’articolo 49, par. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea recita: “nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima”.
Così, purtroppo, non è: lo ha deciso la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, ancora una volta, sulla legittimità dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024, il quale fa decorrere le sanzioni tributarie più favorevoli solo per violazioni commesse dal 1° settembre 2024, derogando, quindi, alla lex mitior dell’invocato articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
In particolare, con l’Ordinanza n. 23149 del 12 agosto 2025, la Cassazione ha giudicato manifestamente infondata la questione di costituzionalità e coerente la scelta d’irretroattività, alla luce della riforma organica delle sanzioni amministrative e di controinteressi costituzionali.
In particolare, la Corte afferma (rectius: conferma) espressamente che la scelta compiuta dal Legislatore con il citato articolo 5 del D.Lgs. n. 87/2024 “non appare in contrasto con i principi costituzionali né con quelli unionali”; ciò in quanto l’irretroattività è bilanciata dalla “modifica radicale del rapporto Fisco/ contribuente” e anche dal rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico. Peraltro, secondo i Giudici, tale ultimo aspetta “riversa direttamente i suoi effetti sul raggiungimento di prestazioni standard in materie di rango costituzionale …quali le prestazioni sanitarie (art. 32 Cost), scolastiche (art. 34 Cost), di sicurezza pubblica, ecc”.
Analoghe considerazioni erano svolte nelle precedenti sentenze nn. 1274/2025 e 17113/2025. Di talché è possibile affermare che l’orientamento giurisprudenziale sta consolidandosi.
Orbene, secondo la Corte, la disciplina in esame riflette un bilanciamento ragionevole tra la garanzia del favor rei e altri valori costituzionali di pari rango e non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., né con il diritto dell’Unione europea o con la CEDU, trattandosi di una deroga puntuale e giustificata da un assetto riformatore di sistema.
Tuttavia, la motivazione fornita, pur nella sua puntualità, non può non lasciare perplessi.
Sotto un primo aspetto, la Corte evidenzia che l’equivalenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale rappresenta sì una regola tendenzialmente ineludibile e inevitabile, ma che tuttavia la stessa non giunge ad una perfetta sovrapposizione dei piani. Ciò in quanto “la stessa natura penale delle sanzioni ha necessità d’essere perimetrata”. In questo senso, come ricorda lo stesso Giudice di legittimità, il richiamo non può che andare alla fondamentale sentenza “Engel” (Corte Edu, 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, Engel and Others/Netherlands), che, nel valutare il profilo del ne bis in idem sanzionatorio tra piano amministrativo e piano penale, ha determinato una serie di criteri in base ai quali, in concreto, la sanzione formalmente amministrativa può essere qualificata come sostanzialmente penale. A tal fine, infatti, devono essere considerati, all’atto pratico, lo scopo afflittivo e non riparatorio della misura, la gravità della misura nella sua applicazione concreta, la rilevanza attribuita dalla disposizione alla gravità del fatto e alla colpevolezza dell’autore.
Ma viene da chiedersi: come si concilia tutto ciò con il principio di proporzionalità?
Ed ancora. Il Giudice di legittimità invoca l’argomento “logico-sistematico”: poiché il comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997 ammette (espressamente) la clausola “salvo diversa previsione” in caso di abolitio, sarebbe “logico” ammettere deroghe anche alla lex mitior del comma 3 (che non contiene clausola di salvezza). Tale argomento, però, sia consentito dirlo, non convince: che fine ha fatto il principio “ubi lex voluit, dixit”?
In ultimo, ma non per ultimo, vi è un clamoroso “eccesso di delega”, in violazione dell’art. 76 Cost.: l’articolo 5 del D.lgs. n. 87/2024, nel prevedere, come detto, una deroga al c.d. “principio di retroattività della sanzione più favorevole”, nel silenzio assoluto sul punto della legge delega, “travalica” abbondantemente i criteri e le direttive stabiliti dalla L. n. 111 del 2023, nella quale ci si limita a fare riferimento ad una razionalizzazione del “sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem» e ad un miglioramento della «proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei”.
In conclusione, l’orientamento di cui alla citata Ordinanza dello scorso agosto, che ritiene legittima la previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 sembra in via di consolidamento, non senza preoccupazioni tra gli esperti del diritto. Il dibattito sul punto è aperto e vivace: il principio di applicazione della lex mitior resta fondamentale del nostro ordinamento e, seppur corretto che non sia assoluto, certamente non può corrersi il rischio che la irretroattività in mitius diventi la regola.
Le aule delle Corti di Giustizia Tributarie, e non solo, saranno teatro di accesi dibattiti.
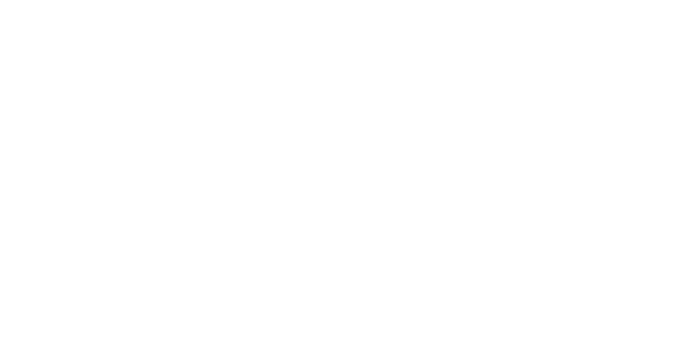
Il principio di retroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli si può derogare?
A cura di Giorgia Sforzini, Associate
Il principio di retroattività delle sanzioni più favorevoli, noto anche come favor rei o principio della lex mitior, può essere derogato?
Verrebbe da dire assolutamente no, considerando che l’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 afferma: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”, e che l’articolo 49, par. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea recita: “nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima”.
Così, purtroppo, non è: lo ha deciso la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, ancora una volta, sulla legittimità dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024, il quale fa decorrere le sanzioni tributarie più favorevoli solo per violazioni commesse dal 1° settembre 2024, derogando, quindi, alla lex mitior dell’invocato articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
In particolare, con l’Ordinanza n. 23149 del 12 agosto 2025, la Cassazione ha giudicato manifestamente infondata la questione di costituzionalità e coerente la scelta d’irretroattività, alla luce della riforma organica delle sanzioni amministrative e di controinteressi costituzionali.
In particolare, la Corte afferma (rectius: conferma) espressamente che la scelta compiuta dal Legislatore con il citato articolo 5 del D.Lgs. n. 87/2024 “non appare in contrasto con i principi costituzionali né con quelli unionali”; ciò in quanto l’irretroattività è bilanciata dalla “modifica radicale del rapporto Fisco/ contribuente” e anche dal rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico. Peraltro, secondo i Giudici, tale ultimo aspetta “riversa direttamente i suoi effetti sul raggiungimento di prestazioni standard in materie di rango costituzionale …quali le prestazioni sanitarie (art. 32 Cost), scolastiche (art. 34 Cost), di sicurezza pubblica, ecc”.
Analoghe considerazioni erano svolte nelle precedenti sentenze nn. 1274/2025 e 17113/2025. Di talché è possibile affermare che l’orientamento giurisprudenziale sta consolidandosi.
Orbene, secondo la Corte, la disciplina in esame riflette un bilanciamento ragionevole tra la garanzia del favor rei e altri valori costituzionali di pari rango e non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., né con il diritto dell’Unione europea o con la CEDU, trattandosi di una deroga puntuale e giustificata da un assetto riformatore di sistema.
Tuttavia, la motivazione fornita, pur nella sua puntualità, non può non lasciare perplessi.
Sotto un primo aspetto, la Corte evidenzia che l’equivalenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale rappresenta sì una regola tendenzialmente ineludibile e inevitabile, ma che tuttavia la stessa non giunge ad una perfetta sovrapposizione dei piani. Ciò in quanto “la stessa natura penale delle sanzioni ha necessità d’essere perimetrata”. In questo senso, come ricorda lo stesso Giudice di legittimità, il richiamo non può che andare alla fondamentale sentenza “Engel” (Corte Edu, 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, Engel and Others/Netherlands), che, nel valutare il profilo del ne bis in idem sanzionatorio tra piano amministrativo e piano penale, ha determinato una serie di criteri in base ai quali, in concreto, la sanzione formalmente amministrativa può essere qualificata come sostanzialmente penale. A tal fine, infatti, devono essere considerati, all’atto pratico, lo scopo afflittivo e non riparatorio della misura, la gravità della misura nella sua applicazione concreta, la rilevanza attribuita dalla disposizione alla gravità del fatto e alla colpevolezza dell’autore.
Ma viene da chiedersi: come si concilia tutto ciò con il principio di proporzionalità?
Ed ancora. Il Giudice di legittimità invoca l’argomento “logico-sistematico”: poiché il comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997 ammette (espressamente) la clausola “salvo diversa previsione” in caso di abolitio, sarebbe “logico” ammettere deroghe anche alla lex mitior del comma 3 (che non contiene clausola di salvezza). Tale argomento, però, sia consentito dirlo, non convince: che fine ha fatto il principio “ubi lex voluit, dixit”?
In ultimo, ma non per ultimo, vi è un clamoroso “eccesso di delega”, in violazione dell’art. 76 Cost.: l’articolo 5 del D.lgs. n. 87/2024, nel prevedere, come detto, una deroga al c.d. “principio di retroattività della sanzione più favorevole”, nel silenzio assoluto sul punto della legge delega, “travalica” abbondantemente i criteri e le direttive stabiliti dalla L. n. 111 del 2023, nella quale ci si limita a fare riferimento ad una razionalizzazione del “sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem» e ad un miglioramento della «proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei”.
In conclusione, l’orientamento di cui alla citata Ordinanza dello scorso agosto, che ritiene legittima la previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 sembra in via di consolidamento, non senza preoccupazioni tra gli esperti del diritto. Il dibattito sul punto è aperto e vivace: il principio di applicazione della lex mitior resta fondamentale del nostro ordinamento e, seppur corretto che non sia assoluto, certamente non può corrersi il rischio che la irretroattività in mitius diventi la regola.
Le aule delle Corti di Giustizia Tributarie, e non solo, saranno teatro di accesi dibattiti.