Premessa.
In un articolo del 2015 su TDM sul ritiro dal Trattato sulla Carta dell’energia (TCE) notificato dall’Italia alla fine del 2014 e la denuncia dal parte della stessa di tutti gli accordi bilaterali di protezione degli investimenti (BITs) con altri Stati membri negli anni 2008-2009, preconizzavamo un destino incerto per il TCE, almeno come trattato multilaterale di origine europea, dato il rischio di un possibile effetto domino, come il recesso di altri Stati membri dell’UE.
La fine del TCE come trattato di cooperazione energetica di origine europea si è materializzata il 30 maggio 2024, con l’annuncio da parte della presidenza belga del raggiungimento in seno al Consiglio dell’UE di un compromesso politico sulla modernizzazione del TCE, risultato di un processo lanciato nel 2018 su impulso europeo e conclusosi con successo nel 2022.
Il compromesso ha consentito di superare la situazione di stallo all’interno dell’UE, che da circa due anni impediva anche alle Parti contraenti del TCE non europee di adottarne il testo modernizzato, dato che gli emendamenti sono approvati all’unanimità. Da una parte, il Consiglio ha approvato il recesso dell’UE (e dell’Euratom) dal TCE, già peraltro autorizzato dal Parlamento europeo nell’aprile 2024, ed effettivo dal 28 giugno 2025 (art. 47(2) TCE). Dall’altra, il compromesso consente agli Stati membri che lo desiderano di rimanere Parte del TCE, approvando o non opponendosi all’adozione del testo modernizzato. Si tratta di un duro colpo per l’ambizione dell’UE quale attore energetico globale e leader nelle energie rinnovabili e un segnale di instabilità politica da parte del blocco europeo in tempi di grande incertezza geopolitica e di ritorno della competizione strategica tra grandi potenze, che richiederebbe al contrario stabilità e certezza del diritto per gli investitori.
Tuttavia, la fine del TCE era già stata segnata dalle notifiche di recesso di Francia, Germania e Polonia nel dicembre 2022 e dalla precedente decisione di alcuni Stati membri nell’ottobre dello stesso anno di non sostenere la proposta della Commissione europea di approvazione del testo modernizzato dell’ECT, a causa di non del tutto specificate e in parte contradditorie preoccupazioni relative alla protezione degli investitori nel settore dei combustibili fossili ed al cambiamento climatico, come detto in altra sede. Nel 2023, anche Slovenia e Lussemburgo hanno notificato il loro recesso, seguiti da Spagna, Portogallo, Paesi bassi e Regno Unito nel 2024.
L’incompatibilità tra investment arbitration intra-UE e diritto dell’Unione europea e il processo di emendamento e modernizzazione del TCE .
L’incompatibilità tra investment treaty arbitration in un contesto intra-UE (vale a dire tra uno Stato membro e gli investitori nazionali di un diverso Stato membro) e il diritto dell’Unione europea è stata posta dalla Commissione europea a partire dal 2008 inizialmente in relazione ai BIT tra Stati membri. Era tuttavia difficile che la questione non imponesse anche una rivalutazione del TCE con riguardo alla sua applicazione intra-UE, nonostante dal punto di vista strettamente giuridico tale applicazione ponesse e tutt’ora ponga criticità diverse rispetto all’investment arbitration basato sui BIT intra-UE (si veda il nostro “Lodo favorevole alla Spagna a conclusione del primo degli investment arbitrations sorti da impianti fotovoltaici: un precedente rilevante?”, Diritto del Commercio Internazionale, 2016, pp.250-275).
Infatti, secondo una giurisprudenza europea consolidata sin dal caso Matteucci (punti 21-22), i Trattati costitutivi dell’Unione prevalgono sugli accordi internazionali tra Stati membri in caso producano effetti in contrasto con il diritto dell’Unione europea (incluso il principio di mutua fiducia tra Stati membri), o ne ostacolino la piena applicazione, come confermato nella sentenza Achmea rispetto ai BIT intra-UE (punti 55-56). Tuttavia, come ribadito dalla Corte di giustizia nella stessa sentenza (punti 57-58), al contrario degli accordi internazionali tra Stati membri, un accordo multilaterale (anche in forma mista) con Stati terzi, di cui anche l’Unione, insieme agli Stati membri, sia parte (come il TCE), che preveda una propria procedura internazionale di risoluzione delle controversie, le cui decisioni vincolino le istituzioni, ivi compresa la Corte, non è, in linea di principio, incompatibile con il diritto dell’Unione (Art. 216,n. 2 TFUE). Quando l’accordo è validamente concluso dall’Unione e dagli Stati membri (come il TCE), eventuali incompatibilità sopravvenute dello stesso con il diritto dell’Unione non liberano le istituzioni dell’Unione (inclusa la Corte) e gli Stati membri dall’obbligo del rispetto delle obbligazioni convenzionali assunte o delle norme di diritto internazionale generale. Si tratta, per esempio, del principio di diritto internazionale generale pacta sunt servanda (art. 26 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969) e il principio secondo cui disposizioni di diritto interno di un Stato contraente dell’accordo non giustificano la mancata esecuzione delle obbligazioni discendenti dallo stesso o violazioni di norme di diritto internazionale (art. 27 Convenzione di Vienna e art. 3 degli Articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato della Commissione di diritto internazionale del 2001).
Dall’altra l’Unione e gli Stati membri hanno l’obbligo di diritto europeo di adoperarsi per rimuovere le sopravvenute incompatibilità dell’accordo internazionale con il diritto dell’Unione sul piano internazionale, tramite la negoziazione di emendamenti della disciplina convenzionale divenuta incompatibile o, se insufficiente, la denuncia dell’accordo stesso sul piano internazionale.
Iniziative europee volte a risolvere tempestivamente le questioni di (in)compatibilità dell’investment arbitration con il diritto dell’UE già emerse nel 2008 sarebbero state coerenti con il principio del rispetto della certezza del diritto per gli investitori europei nel settore dell’energia dato che gli standard di trattamento e protezione del TCE, così come il principio generale del diritto europeo del legittimo affidamento, sono espressione dello stato di diritto.
Tuttavia, queste iniziative europee, sviluppatesi solo dopo il 2018 a seguito della sentenza Achmea, date le insuperabili divergenze interne alla UE, sono state tutt’altro che tempestive e nel caso del TCE del tutto tardive. Per quanto riguarda i BIT tra Stati membri si tratta dell’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell’Unione europea del 2020 (concluso da tutti gli Stati membri eccetto Austria, Svezia, Finlandia e Irlanda). Per quanto riguarda il TCE, si trattava dell’adozione definitiva degli emendamenti del TCE, approvati “in principle” dalla Conferenza della Carta dell’Energia a seguito della conclusione del processo di modernizzazione del trattato.
Quale protezione per gli investitori europei vis-à-vis l’esercizio da parte degli Stati membri dei poteri pubblici?
Considerata l’estinzione tra il 2020 e il 2022 degli accordi bilaterali degli Stati membri, inclusa la possibilità del ricorso all’arbitrato ivi prevista, ai sensi dell’artt. 2 e 4 dell’Accordo di estinzione – ad eccezione dei BIT intra-UE dell’Italia estinti anteriormente, perché denunciati unilateralmente dalla stessa tra il 2008-2010 e rimasti invocabili dagli investitori per un periodo transitorio di 5 anni dalla notifica della denuncia alla controparte secondo la clausola di sopravvivenza standard dei modelli di BIT italiani, come ad esempio nel caso ICSID Gavazzi vs. Romania – agli investitori degli Stati membri con investimenti in altri Stati membri non rimane che testare davanti ai giudici degli Stati membri ospiti dell’investimento la tutela garantita dal diritto dell’Unione, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare, i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, cui grande enfasi è riservata nel Preambolo dell’Accordo, ed eventualmente il ricorso in base alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
A seguito del recesso dell’Unione e degli Stati membri dal TCE prima dell’adozione del testo modernizzato del TCE, gli investitori nel settore dell’energia degli Stati membri receduti potrebbero:
- per gli investimenti effettuati fino alla data in cui il recesso dal Trattato ha preso effetto (un anno dal ricevimento della notifica del recesso da parte del depositario) ricorrere in arbitrato ICSID sulla base dell’articolo 26, che insieme alle altre disposizioni del Trattato “…continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati nell’area di una Parte contraente da investitori di altre Parti contraenti o nell’area di altre Parti contraenti da investitori di detta Parte contraente, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui il recesso dal Trattato prende effetto” (art. 47(3) TCE).
Per l’Italia le disposizioni del TCE si applicano in base alla clausola di caducità di cui all’art. 47 TCE fino al 1° gennaio 2036, essendo il recesso divenuto effettivo il 1° gennaio 2016.
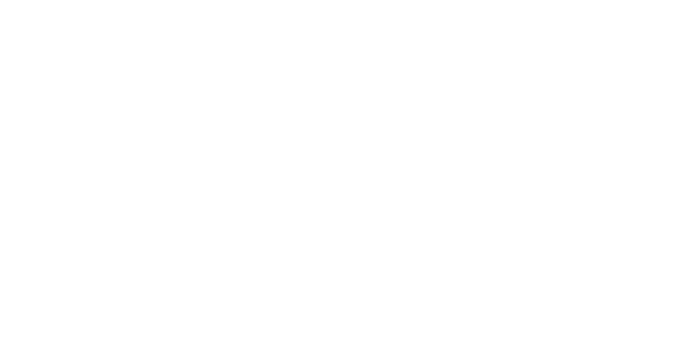
Il ritiro dell’UE e di alcuni (ma non tutti gli) stati membri dal Trattato sulla carta dell’energia: quale protezione per gli investitori europei nel settore dell’energia nell’Unione?
A cura di Anna De Luca, Of Counsel
Premessa.
In un articolo del 2015 su TDM sul ritiro dal Trattato sulla Carta dell’energia (TCE) notificato dall’Italia alla fine del 2014 e la denuncia dal parte della stessa di tutti gli accordi bilaterali di protezione degli investimenti (BITs) con altri Stati membri negli anni 2008-2009, preconizzavamo un destino incerto per il TCE, almeno come trattato multilaterale di origine europea, dato il rischio di un possibile effetto domino, come il recesso di altri Stati membri dell’UE.
La fine del TCE come trattato di cooperazione energetica di origine europea si è materializzata il 30 maggio 2024, con l’annuncio da parte della presidenza belga del raggiungimento in seno al Consiglio dell’UE di un compromesso politico sulla modernizzazione del TCE, risultato di un processo lanciato nel 2018 su impulso europeo e conclusosi con successo nel 2022.
Il compromesso ha consentito di superare la situazione di stallo all’interno dell’UE, che da circa due anni impediva anche alle Parti contraenti del TCE non europee di adottarne il testo modernizzato, dato che gli emendamenti sono approvati all’unanimità. Da una parte, il Consiglio ha approvato il recesso dell’UE (e dell’Euratom) dal TCE, già peraltro autorizzato dal Parlamento europeo nell’aprile 2024, ed effettivo dal 28 giugno 2025 (art. 47(2) TCE). Dall’altra, il compromesso consente agli Stati membri che lo desiderano di rimanere Parte del TCE, approvando o non opponendosi all’adozione del testo modernizzato. Si tratta di un duro colpo per l’ambizione dell’UE quale attore energetico globale e leader nelle energie rinnovabili e un segnale di instabilità politica da parte del blocco europeo in tempi di grande incertezza geopolitica e di ritorno della competizione strategica tra grandi potenze, che richiederebbe al contrario stabilità e certezza del diritto per gli investitori.
Tuttavia, la fine del TCE era già stata segnata dalle notifiche di recesso di Francia, Germania e Polonia nel dicembre 2022 e dalla precedente decisione di alcuni Stati membri nell’ottobre dello stesso anno di non sostenere la proposta della Commissione europea di approvazione del testo modernizzato dell’ECT, a causa di non del tutto specificate e in parte contradditorie preoccupazioni relative alla protezione degli investitori nel settore dei combustibili fossili ed al cambiamento climatico, come detto in altra sede. Nel 2023, anche Slovenia e Lussemburgo hanno notificato il loro recesso, seguiti da Spagna, Portogallo, Paesi bassi e Regno Unito nel 2024.
L’incompatibilità tra investment arbitration intra-UE e diritto dell’Unione europea e il processo di emendamento e modernizzazione del TCE .
L’incompatibilità tra investment treaty arbitration in un contesto intra-UE (vale a dire tra uno Stato membro e gli investitori nazionali di un diverso Stato membro) e il diritto dell’Unione europea è stata posta dalla Commissione europea a partire dal 2008 inizialmente in relazione ai BIT tra Stati membri. Era tuttavia difficile che la questione non imponesse anche una rivalutazione del TCE con riguardo alla sua applicazione intra-UE, nonostante dal punto di vista strettamente giuridico tale applicazione ponesse e tutt’ora ponga criticità diverse rispetto all’investment arbitration basato sui BIT intra-UE (si veda il nostro “Lodo favorevole alla Spagna a conclusione del primo degli investment arbitrations sorti da impianti fotovoltaici: un precedente rilevante?”, Diritto del Commercio Internazionale, 2016, pp.250-275).
Infatti, secondo una giurisprudenza europea consolidata sin dal caso Matteucci (punti 21-22), i Trattati costitutivi dell’Unione prevalgono sugli accordi internazionali tra Stati membri in caso producano effetti in contrasto con il diritto dell’Unione europea (incluso il principio di mutua fiducia tra Stati membri), o ne ostacolino la piena applicazione, come confermato nella sentenza Achmea rispetto ai BIT intra-UE (punti 55-56). Tuttavia, come ribadito dalla Corte di giustizia nella stessa sentenza (punti 57-58), al contrario degli accordi internazionali tra Stati membri, un accordo multilaterale (anche in forma mista) con Stati terzi, di cui anche l’Unione, insieme agli Stati membri, sia parte (come il TCE), che preveda una propria procedura internazionale di risoluzione delle controversie, le cui decisioni vincolino le istituzioni, ivi compresa la Corte, non è, in linea di principio, incompatibile con il diritto dell’Unione (Art. 216,n. 2 TFUE). Quando l’accordo è validamente concluso dall’Unione e dagli Stati membri (come il TCE), eventuali incompatibilità sopravvenute dello stesso con il diritto dell’Unione non liberano le istituzioni dell’Unione (inclusa la Corte) e gli Stati membri dall’obbligo del rispetto delle obbligazioni convenzionali assunte o delle norme di diritto internazionale generale. Si tratta, per esempio, del principio di diritto internazionale generale pacta sunt servanda (art. 26 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969) e il principio secondo cui disposizioni di diritto interno di un Stato contraente dell’accordo non giustificano la mancata esecuzione delle obbligazioni discendenti dallo stesso o violazioni di norme di diritto internazionale (art. 27 Convenzione di Vienna e art. 3 degli Articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato della Commissione di diritto internazionale del 2001).
Dall’altra l’Unione e gli Stati membri hanno l’obbligo di diritto europeo di adoperarsi per rimuovere le sopravvenute incompatibilità dell’accordo internazionale con il diritto dell’Unione sul piano internazionale, tramite la negoziazione di emendamenti della disciplina convenzionale divenuta incompatibile o, se insufficiente, la denuncia dell’accordo stesso sul piano internazionale.
Iniziative europee volte a risolvere tempestivamente le questioni di (in)compatibilità dell’investment arbitration con il diritto dell’UE già emerse nel 2008 sarebbero state coerenti con il principio del rispetto della certezza del diritto per gli investitori europei nel settore dell’energia dato che gli standard di trattamento e protezione del TCE, così come il principio generale del diritto europeo del legittimo affidamento, sono espressione dello stato di diritto.
Tuttavia, queste iniziative europee, sviluppatesi solo dopo il 2018 a seguito della sentenza Achmea, date le insuperabili divergenze interne alla UE, sono state tutt’altro che tempestive e nel caso del TCE del tutto tardive. Per quanto riguarda i BIT tra Stati membri si tratta dell’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell’Unione europea del 2020 (concluso da tutti gli Stati membri eccetto Austria, Svezia, Finlandia e Irlanda). Per quanto riguarda il TCE, si trattava dell’adozione definitiva degli emendamenti del TCE, approvati “in principle” dalla Conferenza della Carta dell’Energia a seguito della conclusione del processo di modernizzazione del trattato.
Quale protezione per gli investitori europei vis-à-vis l’esercizio da parte degli Stati membri dei poteri pubblici?
Considerata l’estinzione tra il 2020 e il 2022 degli accordi bilaterali degli Stati membri, inclusa la possibilità del ricorso all’arbitrato ivi prevista, ai sensi dell’artt. 2 e 4 dell’Accordo di estinzione – ad eccezione dei BIT intra-UE dell’Italia estinti anteriormente, perché denunciati unilateralmente dalla stessa tra il 2008-2010 e rimasti invocabili dagli investitori per un periodo transitorio di 5 anni dalla notifica della denuncia alla controparte secondo la clausola di sopravvivenza standard dei modelli di BIT italiani, come ad esempio nel caso ICSID Gavazzi vs. Romania – agli investitori degli Stati membri con investimenti in altri Stati membri non rimane che testare davanti ai giudici degli Stati membri ospiti dell’investimento la tutela garantita dal diritto dell’Unione, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare, i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, cui grande enfasi è riservata nel Preambolo dell’Accordo, ed eventualmente il ricorso in base alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
A seguito del recesso dell’Unione e degli Stati membri dal TCE prima dell’adozione del testo modernizzato del TCE, gli investitori nel settore dell’energia degli Stati membri receduti potrebbero:
Per l’Italia le disposizioni del TCE si applicano in base alla clausola di caducità di cui all’art. 47 TCE fino al 1° gennaio 2036, essendo il recesso divenuto effettivo il 1° gennaio 2016.