La gestione dei rifiuti nella Regione Lazio rappresenta da anni una delle sfide più complesse, sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo economico.
Il Piano Regionale Rifiuti 2019–2025, approvato con Deliberazione n. 4 del Consiglio Regionale del 5 agosto 2020, fissava obiettivi ambiziosi in tema di autosufficienza territoriale.
Infatti, a fronte della suddivisione del territorio regionale in cinque ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), corrispondenti ai confini provinciali, si sancisce il principio per cui ogni ambito deve essere in grado di trattare e smaltire autonomamente i rifiuti prodotti.
La previsione costituisce l’attuazione dei precetti normativi contenuti nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con il quale si stabiliva che ogni ATO dovesse garantire una dotazione impiantistica idonea a gestire i rifiuti prodotti, riducendo al minimo i trasferimenti verso altre aree, in ossequio ai principi di autosufficienza e di prossimità nella gestione dei rifiuti. Principi, come noto, di matrice comunitaria (Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio).
Tuttavia, la legislazione per principi, sintomatica di una programmazione a lungo termine e più fedele a spinte ideologiche piuttosto che pratiche, sconta il raffronto con le insormontabili difficoltà operative (se non con l’inerzia) delle Istituzioni.
Gli EGATO (Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali), istituiti dalla Legge Regionale 25 luglio 2022, n. 14 per la gestione integrata dei rifiuti urbani, sono stati abrogati poco dopo, con la Legge Regionale 16 novembre 2023, n. 19. Tale abrogazione ha ulteriormente rallentato le attività necessarie al raggiungimento dell’autosufficienza, privando il sistema di un organismo centrale di coordinamento e di supporto indispensabile per tutti gli enti coinvolti.
All’atavica scarsità di risorse (voluta o non) si sono aggiunti e succeduti diversi eventi, tra cui la chiusura dell’impianto di Malagrotta, che per decenni ha rappresentato il fulcro dell’intero sistema di smaltimento della Capitale, e una pluralità di disservizi causati da incendi e guasti ad impianti di trattamento meccanico biologico (TMB).
Alle chiusure di suddetti impianti non è seguita, com’era prevedibile, l’apertura di nuove infrastrutture, con ripercussioni dirette sulla capacità di trattamento locale.
Questi eventi hanno generato, dunque, una prolungata emergenza, comprovata dall’impiego di impianti alternativi, spesso situati in altri ambiti o addirittura al di fuori dei confini regionali.
Per far fronte alla situazione emergenziale, la scena è stata spiacevolmente occupata dai c.d. “extra-costi”, costituiti proprio dalle maggiori spese sostenute dai gestori rispetto alle tariffe standard previste per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
La disciplina relativa alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Lazio, nonché della quota percentuale dovuta dai Comuni gestori ai soggetti gestori delle discariche a favore dei Comuni sedi delle discariche stesse, è regolata dal Decreto Commissariale n. 15 dell’11 marzo 2005.
Il Decreto definisce i criteri metodologici per il calcolo delle tariffe, stabilendo un sistema di controllo e revisione fondato sulla trasparenza e sulla verifica dei costi effettivamente sostenuti dai gestori.
In particolare, i gestori sono tenuti a trasmettere annualmente alla Regione la documentazione contabile, comprensiva del bilancio societario e del rapporto sulle attività dell’impianto oggetto di autorizzazione, con indicazione del capitale investito e del conto economico. Tali documenti devono essere certificati da una società di revisione nominata direttamente dalla Regione Lazio, selezionata nel rispetto del principio di rotazione e iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione, aggiornato annualmente dalla CONSOB.
I competenti Uffici regionali devono esaminare le dichiarazioni dei costi e dei dati tecnici presentate insieme alle relazioni prodotte dalle società di revisione, verificando la congruità dei costi dichiarati rispetto a quelli di mercato, e su tale base deve essere determinata la tariffa di accesso agli impianti.
L’art. 7 del Decreto prevede, inoltre, che la procedura di revisione tariffaria possa essere attivata al verificarsi di specifiche condizioni: i) variazioni superiori o inferiori al 10% dei costi e/o dei quantitativi di rifiuti smaltiti; ii) modifiche alla configurazione impiantistica o alle modalità gestionali che richieda il rilascio di autorizzazione come previsto dall’art. 15 comma 14 della L.R. 27/98; iii) modifiche impiantistiche o gestionali derivanti da situazioni imprevedibili o da modifiche normative.
Dalla lettura del combinato disposto del Decreto Commissariale e del Decreto Legislativo n. 152/2006 emerge che ogni qualvolta il gestore del servizio di smaltimento o trattamento dei rifiuti non raggiunga l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti, si applica la tariffa incrementale prevista.
Tuttavia, una simile misura appare effettivamente punitiva e penalizzante in un contesto come quello laziale, dove i soggetti preposti non dispongono delle condizioni necessarie per perseguire l’autosufficienza stessa. Di conseguenza, ciò che dovrebbe essere un incentivo o uno stimolo ad una gestione virtuosa si trasforma in sanzione, aggravando una situazione patologica causata dalla cronica situazione di inefficienza a livello regionale.
Nel Lazio, dunque, la sistematica impossibilità di gestire i rifiuti “in ambito” ha portato a riconoscere gli extra-costi come una voce ordinaria nei bilanci pubblici, con conseguenti ripercussioni dirette sulle tariffe a carico dei cittadini.
Proprio in considerazione della loro standardizzazione, gli extra-costi sono sempre più spesso oggetto di contenziosi davanti alla magistratura amministrativa.
Le misure normative e tariffarie pensate per incentivare l’autonomia degli ambiti territoriali finiscono, infatti, per tradursi in un meccanismo paradossale: quello che dovrebbe essere uno strumento di riequilibrio territoriale si configura, in pratica, come una sorta di sanzione economica.
Il rischio è quello di un effetto regressivo, dove inefficienze amministrative e ritardi nella pianificazione e autorizzazione gravano su soggetti estranei alle problematiche, con un aumento del costo complessivo del servizio.
L’esperienza del Lazio dimostra che il principio di autosufficienza è difficilmente realizzabile se non supportato da una pianificazione impiantistica coerente e da un’efficace cooperazione tra livelli istituzionali.
Finché la dotazione impiantistica rimane insufficiente, il conferimento fuori ATO è inevitabile, e gli extra-costi, invece di essere un’eccezione, diventano una regola: una componente strutturale del sistema.
Per riportare equilibrio e stabilità economica nel sistema regionale dei rifiuti, sarà indispensabile orientare la programmazione verso investimenti infrastrutturali mirati e assicurare una distribuzione più equa e trasparente dei costi.
L’alternativa sarà alzare bandiera bianca così da riconoscere l’incapacità gestionale nel settore dei rifiuti della Regione Lazio – e non solo – e virare su un centralismo che si credeva ormai superato.
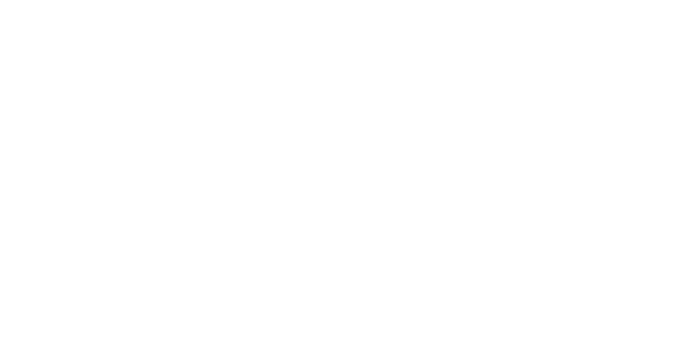
La disciplina degli extra-costi nella gestione dei rifiuti nel Lazio: tra autosufficienza e criticità applicative
A cura di Giorgia Radicetti, Associate
La gestione dei rifiuti nella Regione Lazio rappresenta da anni una delle sfide più complesse, sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo economico.
Il Piano Regionale Rifiuti 2019–2025, approvato con Deliberazione n. 4 del Consiglio Regionale del 5 agosto 2020, fissava obiettivi ambiziosi in tema di autosufficienza territoriale.
Infatti, a fronte della suddivisione del territorio regionale in cinque ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), corrispondenti ai confini provinciali, si sancisce il principio per cui ogni ambito deve essere in grado di trattare e smaltire autonomamente i rifiuti prodotti.
La previsione costituisce l’attuazione dei precetti normativi contenuti nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con il quale si stabiliva che ogni ATO dovesse garantire una dotazione impiantistica idonea a gestire i rifiuti prodotti, riducendo al minimo i trasferimenti verso altre aree, in ossequio ai principi di autosufficienza e di prossimità nella gestione dei rifiuti. Principi, come noto, di matrice comunitaria (Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio).
Tuttavia, la legislazione per principi, sintomatica di una programmazione a lungo termine e più fedele a spinte ideologiche piuttosto che pratiche, sconta il raffronto con le insormontabili difficoltà operative (se non con l’inerzia) delle Istituzioni.
Gli EGATO (Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali), istituiti dalla Legge Regionale 25 luglio 2022, n. 14 per la gestione integrata dei rifiuti urbani, sono stati abrogati poco dopo, con la Legge Regionale 16 novembre 2023, n. 19. Tale abrogazione ha ulteriormente rallentato le attività necessarie al raggiungimento dell’autosufficienza, privando il sistema di un organismo centrale di coordinamento e di supporto indispensabile per tutti gli enti coinvolti.
All’atavica scarsità di risorse (voluta o non) si sono aggiunti e succeduti diversi eventi, tra cui la chiusura dell’impianto di Malagrotta, che per decenni ha rappresentato il fulcro dell’intero sistema di smaltimento della Capitale, e una pluralità di disservizi causati da incendi e guasti ad impianti di trattamento meccanico biologico (TMB).
Alle chiusure di suddetti impianti non è seguita, com’era prevedibile, l’apertura di nuove infrastrutture, con ripercussioni dirette sulla capacità di trattamento locale.
Questi eventi hanno generato, dunque, una prolungata emergenza, comprovata dall’impiego di impianti alternativi, spesso situati in altri ambiti o addirittura al di fuori dei confini regionali.
Per far fronte alla situazione emergenziale, la scena è stata spiacevolmente occupata dai c.d. “extra-costi”, costituiti proprio dalle maggiori spese sostenute dai gestori rispetto alle tariffe standard previste per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
La disciplina relativa alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Lazio, nonché della quota percentuale dovuta dai Comuni gestori ai soggetti gestori delle discariche a favore dei Comuni sedi delle discariche stesse, è regolata dal Decreto Commissariale n. 15 dell’11 marzo 2005.
Il Decreto definisce i criteri metodologici per il calcolo delle tariffe, stabilendo un sistema di controllo e revisione fondato sulla trasparenza e sulla verifica dei costi effettivamente sostenuti dai gestori.
In particolare, i gestori sono tenuti a trasmettere annualmente alla Regione la documentazione contabile, comprensiva del bilancio societario e del rapporto sulle attività dell’impianto oggetto di autorizzazione, con indicazione del capitale investito e del conto economico. Tali documenti devono essere certificati da una società di revisione nominata direttamente dalla Regione Lazio, selezionata nel rispetto del principio di rotazione e iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione, aggiornato annualmente dalla CONSOB.
I competenti Uffici regionali devono esaminare le dichiarazioni dei costi e dei dati tecnici presentate insieme alle relazioni prodotte dalle società di revisione, verificando la congruità dei costi dichiarati rispetto a quelli di mercato, e su tale base deve essere determinata la tariffa di accesso agli impianti.
L’art. 7 del Decreto prevede, inoltre, che la procedura di revisione tariffaria possa essere attivata al verificarsi di specifiche condizioni: i) variazioni superiori o inferiori al 10% dei costi e/o dei quantitativi di rifiuti smaltiti; ii) modifiche alla configurazione impiantistica o alle modalità gestionali che richieda il rilascio di autorizzazione come previsto dall’art. 15 comma 14 della L.R. 27/98; iii) modifiche impiantistiche o gestionali derivanti da situazioni imprevedibili o da modifiche normative.
Dalla lettura del combinato disposto del Decreto Commissariale e del Decreto Legislativo n. 152/2006 emerge che ogni qualvolta il gestore del servizio di smaltimento o trattamento dei rifiuti non raggiunga l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti, si applica la tariffa incrementale prevista.
Tuttavia, una simile misura appare effettivamente punitiva e penalizzante in un contesto come quello laziale, dove i soggetti preposti non dispongono delle condizioni necessarie per perseguire l’autosufficienza stessa. Di conseguenza, ciò che dovrebbe essere un incentivo o uno stimolo ad una gestione virtuosa si trasforma in sanzione, aggravando una situazione patologica causata dalla cronica situazione di inefficienza a livello regionale.
Nel Lazio, dunque, la sistematica impossibilità di gestire i rifiuti “in ambito” ha portato a riconoscere gli extra-costi come una voce ordinaria nei bilanci pubblici, con conseguenti ripercussioni dirette sulle tariffe a carico dei cittadini.
Proprio in considerazione della loro standardizzazione, gli extra-costi sono sempre più spesso oggetto di contenziosi davanti alla magistratura amministrativa.
Le misure normative e tariffarie pensate per incentivare l’autonomia degli ambiti territoriali finiscono, infatti, per tradursi in un meccanismo paradossale: quello che dovrebbe essere uno strumento di riequilibrio territoriale si configura, in pratica, come una sorta di sanzione economica.
Il rischio è quello di un effetto regressivo, dove inefficienze amministrative e ritardi nella pianificazione e autorizzazione gravano su soggetti estranei alle problematiche, con un aumento del costo complessivo del servizio.
L’esperienza del Lazio dimostra che il principio di autosufficienza è difficilmente realizzabile se non supportato da una pianificazione impiantistica coerente e da un’efficace cooperazione tra livelli istituzionali.
Finché la dotazione impiantistica rimane insufficiente, il conferimento fuori ATO è inevitabile, e gli extra-costi, invece di essere un’eccezione, diventano una regola: una componente strutturale del sistema.
Per riportare equilibrio e stabilità economica nel sistema regionale dei rifiuti, sarà indispensabile orientare la programmazione verso investimenti infrastrutturali mirati e assicurare una distribuzione più equa e trasparente dei costi.
L’alternativa sarà alzare bandiera bianca così da riconoscere l’incapacità gestionale nel settore dei rifiuti della Regione Lazio – e non solo – e virare su un centralismo che si credeva ormai superato.